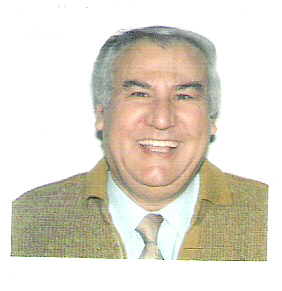Villa Erba, residenza di Visconti a Cernobbio
2 novembre 1906 nasce a Milano Luchino Visconti di Modrone conte di Lonate Pozzolo. Per la sua attività di regista cinematografico e teatrale e per le sue sceneggiature, è considerato uno dei più importanti artisti e uomini di cultura del XX secolo. Assieme a Roberto Rossellini e Vittorio De Sica è ritenuto uno dei padri del Neorealismo italiano. Ha diretto numerosi film a carattere storico, dove l'estrema cura delle ambientazioni e le perfette ricostruzioni sceniche sono state ammirate e imitate da intere generazioni di registi.
Figlio quartogenito del duca Giuseppe Visconti di Modrone e di Carla Erba, proprietaria della più grande casa farmaceutica italiana, fratello minore di Guido, Luigi ed Edoardo, maggiore di Giovanna, Nane e Uberta, è discendente diretto di Francesco Bernardino Visconti, l'Innominato di Manzoni. Presta servizio militare come sottufficiale di cavalleria a Pinerolo e vive gli anni della sua gioventù nell'agio di una delle più importanti famiglie d'Europa. Frequenta, con alterni risultati, il liceo classico Berchet di Milano, dove è bocciato al ginnasio, passa poi al Liceo classico Dante Alighieri diretto dalla famiglia Pollini. A soli ventisei anni, Luchino guiderà una scuderia di cavalli di sua proprietà raggiungendo ottimi risultati tra i quali si ricorderà la vittoria nel Gran Premio di Milano San Siro con Sanzio.
Fin da ragazzo studia violoncello ed è influenzato dal mondo della lirica e del melodramma: il padre è, infatti, uno dei finanziatori del Teatro alla Scala e il salotto di casa Visconti è frequentato, tra gli altri, da Arturo Toscanini. Numerosi artisti sono ospitati anche nella residenza cernobbiese di Villa Erba, sul Lago di Como, dove il giovane Visconti trascorre saltuariamente le vacanze estive con la madre Carla. Così la ricorda il regista: « Villa Erba è una casa che noi amiamo moltissimo. Ci riuniremo tutti là, fratelli e sorelle e sarà come al tempo in cui eravamo bambini e vivevamo all'ombra di nostra madre».
È di questi giorni l’uscita in versione restaurata da Scorsese del Gattopardo cinematografico, che da oggi torna nelle sale, a cinquanta anni dalla prima uscita, nella versione restaurata da Titanus e Cineteca di Bologna, assieme a Martin Scorsese con il sostegno di Gucci, risentì della polemica politica che aveva accompagnato il libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa da cui era stato tratto. Per definire la querelle intorno al libro, la frase migliore è «contrordine compagni», una formula satirica per ironizzare sulla abitudine della vecchia sinistra a obbedire velocemente ai leader che indicavano la necessità di un cambiamento di direzione ideologica.
La sorpresa è che l’ordine abbia riguardato, a suo tempo, uno dei titoli più importanti nella storia del cinema e della letteratura mondiali: «Sulle prime gli intellettuali di sinistra non lo apprezzarono e lo bollarono di anti-storicismo». Per criticarlo scesero in campo in tanti, in testa il dirigente comunista Mario Alicata, «leader culturale del Pci», che «scelse di fare pollice verso» perché il testo conteneva l’«apologia di un mondo passato, raccontato e idealizzato da un aristocratico», provocando il «ridimensionamento di un mito rivoluzionario come quello del Risorgimento» ed esprimendo una forma di «pessimismo nei confronti di qualsiasi forma di progresso».
Alla crocifissione parteciparono in tanti, perfino Alberto Moravia che, come ricorda Eugenio Scalfari in La sera andavamo in via Veneto, «diffidava», forse perché «vedersi portar via il primato della narrativa da un romanzo storico, conteso per di più dalla tradizione e dall’avanguardia», era quanto di peggio potesse capitare. Lo sdoganamento, raccontano Anile e Giannice - vincitori l’altra sera ad Agrigento, durante la trentacinquesima edizione dell’Efebo d’oro, del premio del Sindacato giornalisti cinematografici «Libro di cinema dell’anno» - arriva dalla Francia, dopo la schiacciante vittoria del premio Strega, con l’intervento di Louis Aragon su Les lettres françaises: «In pratica Aragon disse ai compagni italiani che il romanzo era una critica dal di dentro di una classe aristocratica perdente».
Fonti: Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Foto: www.villaerba.it