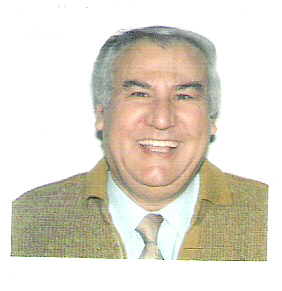Null’altro, in coscienza, si era in grado di capire.
Negli anni, si è prestata assidua attenzione, allo svolgersi delle grandi mostre a Villa Olmo di Como. Anno per anno in una qualche maniera si è cercato di lasciar traccia, nell’intento di conoscere, per quanto possibile, sia l’allestimento, sia la gestione. Null’altro, in coscienza, si era in grado di capire per «dotta ignoranza» e con questo non s’intende evidenziare qualcosa di negativo, «ossia il non sapere di per sé, quanto piuttosto sottolineare l'aspetto positivo di questo non sapere, riprendendo in questo senso lo sceticismo: il fatto di non sapere diventa stimolo a sforzarsi di sapere». Il concetto di «Docta ignorantia» contiene un ossimoro, cioè una figura retorica in cui un termine è l'opposizione dell'altro. Si parla di «ignorantia», ma si definisce «dotta»[1].
Istruita c'è parsa, in tutti questi anni, sia la pratica del governo sia la curatela delle mostre assunte dall’assessore alla cultura. È con non celata immodestia, che si deve rilevare la discutibile avvedutezza sociale. La sollecitazione a far conoscere già nella fase di studio, le strategie e i contenuti delle mostre, mirava a rendere partecipe il cittadino «erudendolo» con l’opportuno decentramento culturale. A onor del vero se non «godimento estetico» certamente conoscenze impersonali se ne sono avute. Il fatto stesso che ogni rassegna fosse stata condizionata da tempi di organizzazione piuttosto contenuti non giustifica disattenzioni. Peraltro le fasi sono state realizzate sempre con il conseguito del miglior successo: seppure nella costrizione si é sempre esultato.
L'ambizione voleva fossero i fatti a risolvere le problematiche che semplicemente si sollevavano. Nella ricerca del senso della misura e della proporzionalità, mentre si prendeva atto del risultato e del significato addotto come argomento per far presa sul pubblico, si faceva proposta affinché l’intrapresa orientata alla cultura potesse essere l’economia del futuro basata su un sistema produttivo e competitivo derivato da un sapiente investimento nei propri cittadini. Il sistema voleva essere un punto di riferimento per esplorare e cogliere le potenzialità dell’investimento in cultura, una risorsa per attivare e mantenere il dialogo con la comunità; uno stimolo per le amministrazioni pubbliche ad interpretare al meglio il loro ruolo di «regia», indispensabile per creare un circolo virtuoso in grado di produrre benefici per il territorio e la collettività. Su questi principi si basa e s’incardina l’economia dell’immateriale, che non scalza quella «tradizionale», ma ne rinverdisce i meccanismi del valore economico, potenziando la portata competitiva.
Iperbole o misura? Esuberanza o proporzionalità? Gli Impressionisti salutano Como con un nuovo record d’ingressi. Il finale, come sempre, è stato vissuto tra musica, fuochi d'artificio e spettacoli teatrali. Villa Olmo, chiusa la mostra, la festa di colori accende la notte. Una grande mostra e un finale «ottocentesco» alla sua altezza. Che notte la notte di Villa Olmo con la festa di chiusura della rassegna: danze, musiche, scene teatrali, fiaccole e fuochi d'artificio. Como saluta con la leggerezza delle ballerine che danzavano nella fontana di Villa Olmo, con la dolcezza della musica di un pianoforte a coda, con la drammaticità del teatro e con la maestosità dei fuochi artificiali. E così ogni anno per tutti gli anni: quest’anno no! Non se la preda Dott. Gaddi, accetti il nostro augurio ed un grazie infinito. A noi ci sono bastate le «conoscenze generiche». Per Ella è alle viste un futuro radioso!
«L’artista italiano del rinascimento era assetato d’idealità e di perfezione (…) La realtà terrena era sì per lui, come per Anteo[2], necessaria per riprendere vita e vigore: ma il suo vero mondo era quello dei miti e delle figure eroiche, dei semidei e delle donne divine, chiamate con nomi cristiani, ma in realtà abitatrici di una terra innocente ignara di colpe originali e di ansie di redenzione. Il ritorno alla terra e alla realtà visibile era il ritorno di un’umanità già vissuta nel paradiso terreste dell’esperienza precristiana. Con Bruegel la rinascita fiamminga vuole essere davvero, pur senza declamazioni programmatiche e rivoluzionarie, un ritorno alla terra, alla vita, alla rude avventura terrena».
[2]Anteo era re di Libia, figlio di Poseidone e di Gea. Egli era praticamente invincibile finché rimaneva a contatto con sua madre (la Terra), che gli restituiva le forze ogni volta che la toccava.