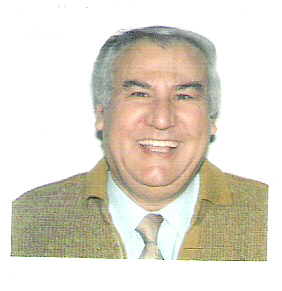Si vuole una città della conoscenza.
Si vuole una città della conoscenza. Non altro dalla città turistico-culturale, ma un suo ampliamento. «Non c’è niente di più politico di questa chiacchierata impolitica, almeno questa è l’impressione che ci portiamo dietro, in strada». È Giovanni Sallusti che ci propone sotto forma di un dialogo ininterrotto con il presidente della Camera di Commercio di Como. Sfruttare la propria collocazione e non subirla, è già un imperativo politico inderogabile. Che si fa, da subito, una questione di metodo: «Su qualunque tema urbano si decida di lavorare, andrà calato l’approccio della rete: la rete di relazioni, di scambi, certamente non solo economici, ma anche culturali».
Puntuale ed intricante l’epilogo che fa il giornalista sul contributo politico della «chiacchierata»: abili, autorevoli e concreti gli argomenti proposti e circostanziati dal Presidente della Camera di Commercio. Tanto simili, a me pare, al proponimento dell’Assessore alla Cultura di Como: «la città deve ripartire per diventare quello che merita di essere. Una città ordinata, creativa e dinamica, che investe nei giovani, ma si prende cura dei bisogni di tutti, capace di unire le opportunità del turismo e della cultura con la sua tradizione di eccellenza produttiva e commerciale».
A mo di passatempo ho da sempre seguito lo svolgersi delle iniziative culturali, in particolar modo le «Grandi Mostre», cercando l’apprendimento ed il possibile «godimento estetico», ma anche il tentativo di sollecitare la conoscenza per far sì che l’uomo diventi «l’artefice del futuro personale e dell’umanità intera». L’idea di un’affascinante dimensione «dell’economia fondata sulla conoscenza». «La città della conoscenza»: un disegno urbano tanto rivoluzionario nella sua profonda prospettiva democratica? Se oggi i mezzi di produzione risiedono realmente nella mente dei produttori, allora assisteremo ad una maggiore diffusione dell’uguaglianza delle opportunità dal momento che chiunque potrà generare una grande idea.
Le fonti delle diseguaglianze e i principi fondamentali della stratificazione sociale vanno ricercati non solo nell'ambito dell'economia, ma anche nella sfera della cultura e in quella della politica. Nella sfera economica gli individui si uniscono sulla base d’interessi materiali comuni, formando le classi sociali, nella sfera della cultura essi seguono comuni interessi ideali e danno origine ai ceti; nella sfera politica, gli individui si associano in partiti o in gruppi di potere per il controllo dell'apparato di dominio. Dunque, secondo Weber non solo la classe, ma anche il ceto e il gruppo di dominio sono fattori essenziali per la comprensione dei processi di stratificazione.
Il concetto di ceto, e più in particolare di condizione di ceto acquista fondamentale importanza. Un ceto è composto da individui che hanno in comune un medesimo stile di vita ed è quindi espressione del grado di partecipazione individuale al "prestigio" sociale. Questo prestigio, però, non è dato solo dalla ricchezza, cioè dal possesso di beni materiali, ma anche da altri fattori. Secondo Weber, solo la condizione di ceto può assicurare una comune base all'agire. L'attenzione va quindi posta sui fattori anche psicologici, che determinano sia le condizioni dell'agire individuale, sia la suddivisione stessa delle persone in gruppi sociali di diverso rango e prestigio; ciò, beninteso, senza trascurare la struttura economica, che resta pur sempre la base per la comprensione della stratificazione sociale.