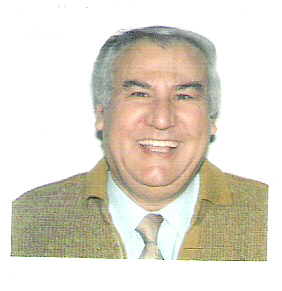Correre ai fatti per sopperire ai misfatti!
«Traspare, dall'esame degli atti, la poco confortante sensazione che un intero insieme di apparati dirigenti, preposti alla tutela dei forti valori paesaggistici» del lungolago «e al controllo della bontà progettuale degli interventi abbia di volta in volta preferito adagiarsi in comportamenti e atteggiamenti improntati al laissez faires, non è dato sapere se spontanei o magari suggeriti dall'alto, cioè da chi avrebbe probabilmente tratto un vantaggio in termini di visibilità politica» «Sono state assunte - si legge nella consulenza - decisioni improvvide e affrettate, spesso limitandosi ad analisi superficiali delle problematiche e suggerendo blande prescrizioni». «scarsa profondità d'analisi e colpevole carenza di quelle attenzioni, di quelle competenze e di quelle sensibilità che sarebbero state necessarie» in un cantiere di un simile «impatto» per il volto della città.[1]
Sobrietà si osserva a Dogliani nel rievocare la figura di Luigi Einaudi a cinquanta anni dalla scomparsa. La lezione di Einaudi è di grande attualità. S’invita a non limitarsi all'esperienza presidenziale di Einaudi ma a recuperare anche aspetti importanti del suo pensiero, dall’eredità di «riformista e precursore della scelta federalistica ed europea. E c'è poi da riflettere pure su aspetti misconosciuti del pensiero di Einaudi come quella che potremmo chiamare con molta approssimazione la sua dimensione sociale». Vi è più che mai bisogno oggi di recuperare «tutti questi nutrimenti per portare la politica e la dialettica politica nelle istituzioni a livello di dignità». L'altro invito è a riflettere «con spirito nuovo» anche su famosi e un «po’ equivocato momento di dibattito», come quello tra Croce ed Einaudi.[2]
Bisogna tornare a scuola di liberalismo e liberismo: non c’è maestro migliore di chi viene citato oggi troppe volte a sproposito, Luigi Einaudi. Riprendendo una vecchia polemica con Croce, e condannando ogni forma di comunismo, nel 1948 Einaudi scriveva sul «Corriere della sera» un elogio della «libertà dell’uomo comune» accettando la tesi che la libertà politica debba essere accompagnata dalla libertà economica : «a che serve la libertà politica a chi dipende da altri per soddisfare i bisogni elementari della vita? Fa d’uopo dare all’uomo la sicurezza della vita materiale, dargli la libertà dal bisogno, perché egli sia veramente libero nella vita civile e politica… La libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica…».[3]
Mentre in Gran Bretagna Keynes proponeva una riforma nei metodi e negli obiettivi della politica economica che rifiutava il laissez-faire per enfatizzare le componenti di progresso e giustizia sociale del liberalismo, in Italia Luigi Einaudi era impegnato in un dibattito decennale con Benedetto Croce sul significato e sulle implicazioni delle nozioni di liberalismo e liberismo. «L’idea liberale» secondo Benedetto Croce «vuole libertà per tutti». La dottrina del laissez - faire é meno ecumenica. Quando Colbert chiese al mercante Legendre «Que faut-il faire pour vous aider? La risposta di Lgendre fu «Nous laisser faire». La differenza è tra quel «tutti» e quel «Nous».[4]
Liberismo: in senso ampio, sistema imperniato sulla libertà del mercato, in cui lo Stato si limita a garantire con norme giuridiche la libertà economica e a provvedere soltanto ai bisogni della collettività che non possono essere soddisfatti per iniziativa dei singoli «in tal senso è detto anche liberalismo o individualismo economico».[5]