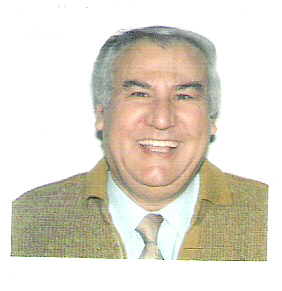Curiosità: l’acqua nei secoli.
Secoli bui quelli medioevali? La disputa è aperta. Senz´altro furono "secoli asciutti." Sì perché l´acqua, sebbene lodata da San Francesco nel Cantico delle Creature, fu in quel periodo oggetto di aspre critiche da parte del ferreo moralismo cristiano che vedeva nella pratica dei bagni un veicolo di eccitazione dei sensi. E, se pur con qualche riserva, si può comprendere, anche se non giustificare, la crociata contro i bagni pubblici, considerati luoghi licenziosi e peccaminosi, mal si interpreta invece il divieto di praticare il bagno privato. Entrando però nell´ottica degli ecclesiastici del tempo appare tutto chiarissimo: immergersi nell´acqua calda dà piacere, il corpo si rilassa, si ritempra. E ciò va assolutamente evitato anche a costo di sacrificare l´igiene personale. Solo in rarissimi casi, nelle idroterapie prescritte dai medici per esempio, all´acqua veniva riconosciuto un ruolo salutare. Ma durò poco. Con le pestilenze del XVI secolo l´acqua fu sempre più messa al bando.
A noi pare un controsenso. Perché tanto astio nei confronti di bagni d´acqua e di vapore in un periodo di infezioni, quando le pratiche igieniche avrebbero dovuto al contrario essere aumentate? A quel tempo si temeva che il calore e l´acqua potessero aprire fessure nella pelle umana. Da lì la peste, la temutissima peste, sarebbe entrata nel corpo, contagiandolo irreparabilmente. Altro che curarsi con l´acqua. Diventava assolutamente necessario evitare i bagni: dai pori allargati si infiltrava aria malsana mentre se ne uscivano sostanze vitali. Le precauzioni da prendere, vista la permeabilità della pelle e la fragilità dei corpi, non erano mai troppe, specie per i bambini. Alle credenze del tempo non sfuggì nemmeno il futuro Luigi XIII, le cui gambe dalla nascita furono lavate solo al compimento del suo settimo anno d´età, in pieno rispetto dei dettami dell´epoca.
Solo col secolo dei Lumi, senza più il timore di censure ecclesiastiche o di eventuali contagi, si tornò a parlare dell´uso terapeutico delle acque, rifacendosi alla medicina greca e alle pratiche termali romane. Ippocrate, il così detto "dottore dell´acqua", con il suo Patologia degli umori, diventò un riferimento insostituibile per gli studi idroterapici del settecento. Infatti a lui, medico greco del V secolo a.C., che si deve la prima trattazione su basi scientifiche del potere curativo dell´acqua. Secondo Ippocrate il buon funzionamento dell´organismo umano dipendeva dai liquidi in esso presenti e l´acqua, applicata calda o fredda sul corpo, facilitava enormemente la circolazione di tali liquidi, arrecando sollievo in caso di malattia. A dire il vero i procedimenti idroterapeutici erano già in uso da millenni, circondati però da un alone di mistero e di sacralità. Immergersi nell´acqua per i popoli della Mesopotamia, per Egiziani, Ebrei, Cretesi così come presso le civiltà orientali, aveva un profondo significato religioso. Solo in seconda battuta si considerava l´aspetto curativo e igienico. Nell´antico Egitto si riteneva per esempio che l´acqua del Nilo fosse un dono divino e a essa si attribuiva ogni efficacia per la cura di coliche renali, infiammazioni e malattie del fegato e della milza.
Sebbene caldamente raccomandati da Ippocrate, i bagni rimasero, per un certo periodo, esclusivo appannaggio di famiglie aristocratiche che potevano permettersi sale da bagno private. Solo in epoca ellenistica cominciarono a diffondersi bagni pubblici e terme. Ma i veri cultori delle terme non furono tanto i Greci, quanto i Romani. Non c´è angolo del loro esteso impero che non ne rechi traccia. Le costruivano ovunque: in piccoli centri, in villaggi, negli scali marittimi, nei porti fluviali e anche presso i loro accampamenti ai confini dell´impero. Le più rinomante, soprattutto quanto a lusso e sfarzi, marmi e pregiate decorazioni pittoriche, furono le terme di Roma, caput mundi. Ogni giorno in migliaia le frequentavano e non solo per avere corpi puliti e profumati. Alle terme si faceva vita sociale, si chiacchierava, si assisteva a spettacoli teatrali, si ammiravano opere d´arte, si ascoltava musica. Nulla da invidiare ai nostri moderni centri di benessere. Centri in cui molto spesso ci vengono, guarda caso, proposti proprio trattamenti idroterapici.
La moderna idroterapia, si è detto, comincia a fare capolino, dopo i "secoli asciutti"medioevali, nel diciottesimo secolo. Dal medico inglese Sir John Floyers a Padre Bernardo Maria da Castrogiano, dal clinico tedesco Hoffmann al medico napoletano Crescenzo, dal dottor Geoffroy, a Siegmund Hahm: tutti loro contribuirono nel corso del Settecento a far luce sui benefici effetti dei rimedi a base d´acqua. E procedimenti messi a punto in quel periodo (come il metodo Priessnitz) vengono ancor oggi utilizzati. A poco a poco tornarono in auge anche le terme, cadute in disgrazia con la fine dell´impero romano. Vera novità del periodo furono però le stazioni balneari: alle virtù terapeutiche dell´acqua si univano i benefici effetti della sabbia e dell´aria marina. I primi bagni, non certo attrezzati come li vediamo ai nostri giorni, sorsero in luoghi ancor oggi di moda: Livorno e Viareggio. Non pensate però alla moderna Viareggio: niente svaghi o divertimenti. Tutto era in funzione dell´acqua, un´acqua che finalmente si riscattava dopo essere stata ingiustamente messa sotto processo.
Da allora "nostra sorella acqua" non ha avuto altro che un susseguirsi di riconoscimenti in campo medico: dalla balneoterapia alla talassoterapia, dai bagni di Khune a quelli di Kneipp, dalle docce scozzesi agli impacchi con additivi fitoterapici, dai bagni di vapore all´idromassaggio, alle inalazioni, per citare solo alcune delle molte varianti terapeutiche dell´idroterapia. Da non dimenticare infine il suo insostituibile aiuto nei centri per la riabilitazione articolare: in acqua, come ci insegna il principio di Archimede, è più facile muoversi in quanto il corpo risulta decisamente più leggero. Il nostro, non c´è che dire, è proprio un "secolo bagnato": ben vengano tutte le applicazioni terapeutiche a base d´acqua. Ma ricordiamoci sempre che l´acqua è una risorsa preziosa, guai a sprecarla.