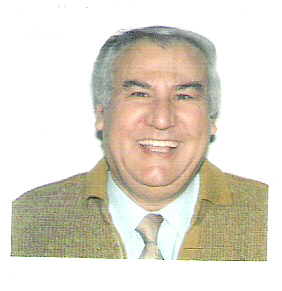Una ghiotta occasione per interloquire da discente.
Per quanto abbia potuto io assecondare la ghiotta occasione per interloquire da discente con spontanee iniziative, mai avrei dovuto ardire, audacia in ambito linguistico e culturale. In realtà così non fu né voleva esserlo: «mi piacerebbe conoscere la lingua inglese almeno come te, per confutare la partigianeria dell’Economist sulla politica italiana; mi piacerebbe avere l’acume e la spontaneità di un satirico per ridicoleggiare gli argomenti dell’autore dell’articolo e sostenere la mia convinzione che pare essere l’opinione dei più, della maggioranza degli italiani». Tanto ebbi a scrivere con pieno convincimento e nient’altro. Ho motivo ed elementi per dimostrare quanto rispetto e riconoscenza ho sempre avuto per la persona ed il livello culturale che ho potuto distinguere anche per la confidenza accordatami, accettando la mia necessità di progredire e combinandomi lassi di tempo e suggerimenti; per questo mi dico immensamente grato.
Anche se con un certo piglio, così Riccardo Paterni interagisce in questo caso: «…Aldilà delle barriere linguistiche e anche culturali quello che a me preoccupa è proprio ciò a cui ti riferisci 'la maggioranza degli Italiani'... detta spesso anche 'il popolo' ... a livello globale è sempre più indispensabile un dinamico spirito critico e costruttivo che vada ben oltre semplici lealtà di facciata». Per poi “discettare” sulla « parola 'popolo' che ormai ha perso il suo significato reale assumendone altri…».
…uno scambio interattivo osservabile fra due o più partecipanti, dotato di intenzionalità reciproca e di un certo livello di consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione secondo la cultura di riferimento. (Anolli, 2002, p.26). Sempre per Anolli bisogna fare attenzione a distinguere la comunicazione, dal comportamento, dall'informazione e dall'interazione. Infatti, il comportamento corrisponde ad una qualsiasi azione motoria messa in atto da un individuo, per svariate ragioni anche di natura riflessa, e percepibile da un altro. E mentre ogni comunicazione presuppone un comportamento, non è vero l'inverso. Per questo Anolli sottolinea come Watzlawick, Beavin e Jackson, sovrapponendo i concetti di comunicazione e comportamento hanno inficiato la possibilità di comprensione della specificità della comunicazione.
D'altro canto, l'informazione è un processo di acquisizione di conoscenze, inferite autonomamente da chi le elabora, in base alla sua capacità, rispetto un certo oggetto o soggetto. L'interazione è invece quel contatto, anche involontario, tra individui, che va a modificare la situazione preesistente delle cose tra loro. L'interazione non è necessariamente intenzionale e quindi non implica necessariamente una comunicazione. L'interazione si trova in posizione intermedia tra la comunicazione e il comportamento.
-
la funzione proposizionale, in quanto le conoscenze sono organizzate e trasmesse sotto forma di proposizioni e quindi si ricorre al linguaggio per poter concettualizzare, significare e comunicare il proprio pensiero;
-
la funzione relazionale, in quanto la comunicazione genera e rinnova le relazioni generando quell'intersoggettività dialogica che consente di negoziare significati e condividere scopi.
Felice Cimatti in "Fondamenti naturali della comunicazione" sostiene che: «…la comunicazione non è un fenomeno autosufficiente, ma rappresenta uno sviluppo delle interazioni non ancora comunicative che hanno luogo nella percezione…La percezione costituisce, in questa ipotesi, il fondamento della comunicazione. La comunicazione, in quanto fenomeno naturale, non sarebbe altro che la trasposizione a livello semiotico della più antica (evolutivamente) e generale capacità non semiotica di percepire e spostarsi nello spazio; con la differenza che, nella comunicazione, lo spazio fisico diventa uno spazio mentale. (Cimatti, 1999, p.86)
Un’osservazione molto interessante e a cui sarebbe opportuno dedicare uno studio approfondito, è il peso che all’interno della storia del pensiero politico hanno ricoperto e tuttora ricoprono parole di cui è alquanto problematico stabilire l’estensione. Una fra tutte, fondamentale all’interno del concetto stesso di democrazia, è la parola “popolo”. Che cosa denota “popolo”? Oppure, più semplicemente, che cosa significa? Che cos’è? La definizione di “popolo” rimanda solitamente a un altro termine intensionale, cioè “massa”, che ovviamente suscita le stesse domande. Sembra perciò di entrare in un circolo vizioso. Norberto Bobbio, di fronte allo stesso problema, sosteneva che l’origine della parola “popolo” dovesse essere ricercata nell’immagine che ognuno si può fare guardando dall’alto un gran numero di persone riunite in un certo luogo (sia questo l’agorà ateniese o lo stadio di San Siro). Anche se la spiegazione può sembrare, almeno intuitivamente, soddisfacente, resta comunque la presenza di numerosi altri termini intensionali all’interno del pensiero e della prassi politica.
Riferimenti