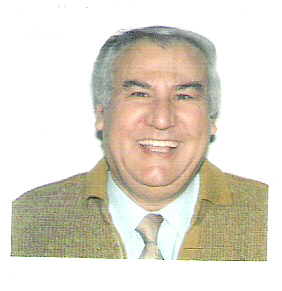I cittadini, attori sociali, possano dare libera espressione alla propria soggettività e risposte ai propri bisogni.
Troppo spesso accade che a seguito di promesse disattese o dietro negletti schemi di compiacenti delegati, sono trascurate legittime necessità a scapito di una parte della comunità. Perseguire finalità di ricupero e sviluppo, con l’individuazione e l’approfondimento di taluni bisogni, può essere un modo per rimediare il declino del senso civico, contrastare la crisi dello stato sociale e di comporre altrimenti la contraddizione di fondo, tra società avanzata e bisogni sociali insoddisfatti.
Tali finalità possono essere conseguite tramite interventi orientati a promuovere “azioni che incidino sulle condizioni della persona nel cercare soddisfazione ai propri bisogni (sociali, economici, culturali), condizioni che costituiscono un ostacolo all’esercizio sostanziale dei propri diritti. L’individuo è il soggetto centrale della Società, il rispetto delle inclinazioni, delle ambizioni, delle passioni è secondario al soddisfacimento di quelle condizioni che ne possono maturare la crescita. Indispensabile quindi l’indipendenza dalle esigenze primarie quali l’alimentazione, l’abitazione, le cure preventive e la crescita culturale. Così come la Società si deve impegnare a dare dignità all’individuo così questi deve desiderare di vedersi realizzato secondo le proprie predisposizioni”.
Apparentemente singolare, può considerarsi la ricerca di relazione con il territorio, perfino nel fruire di servizi sociali e assicurazioni essenziali pubbliche per tutti gli abitanti, secondo misure uniformi, cioè diritti eguali per tutti. L’originalità, rispetto ad una considerazione dell’intervento pubblico destinato per esempio al riordino del territorio stesso, consiste nel considerare l’intervento, espressione essenziale della eguaglianza dei cittadini posta a base della loro appartenenza. Lo stesso cittadino a sua volta che partecipa all’identificazione della necessità e all’approfondimento in loco nell’indagine di fattibilità, diviene un solerte protagonista “curatore” interessato e quindi residente soddisfatto.
I cittadini con alto senso civico, rispettano la propria città, hanno riguardo e vogliono che sia tenuta in alta considerazione. Per questo pagano le tasse, partecipano alle consultazioni politiche per avere la più consona amministrazione e, di solito, nel momento in cui l'interesse dell'amministratore è corrispondente al sentire comune, i cittadini si sentono appagati dell'appartenenza con il raggiungimento dello scopo. Le condizioni ambientali del proprio territorio mostrano il grado di civiltà di un popolo. L'agibilità delle strade e la tranquillità delle proprie residenze: percorribile le prime, raggiungibile le seconde, in ogni circostanza, danno la dovuta serenità, per la partecipativa appartenenza, ai singoli e possono essere l'orgoglio di chi amministra.
Un’esemplificazione in base a criteri fondamentali, circa le linee strategiche di politica ambientale, la promozione e lo sviluppo d’iniziative che orientino la produzione, la gestione e il consumo di beni e servizi verso uno sviluppo compatibile con l'ambiente, nell’interesse del medesimo cittadino fruitore. Capita col verificarsi di fatti contingenti che il governo della città deleghi, ad altri, servizi che non possono essere svolti dalle strutture comunali con produttività. Solitamente si ricorre a gare di appalto la cui aggiudicazione è fondata solamente sul contenimento del prezzo, sorvolando sulla dovuta attenzione affinché non siano trascurati la qualità, l'attinenza ed il rispetto delle clausole del capitolato d’appalto e delle specifiche relative. Attente valutazioni dell’ambiente, scrupolo nel servizio e soddisfacimento dell’utenza devono essere prerogative dell’azienda appaltatrice. Rimane, in ogni caso, all’amministratore o a chi ne fa le veci l’onere di valutare e tutelare la congruità tra l’assolvimento del servizio ed il gradimento del servizio stesso al cittadino utente. Ciò non toglie che il presupposto fondamentale per tale garanzia è un’efficiente struttura con dei processi organizzativi. Il venir meno di tale presupposto genera contraddizione, tra organizzazione strategica e bisogni insoddisfatti del cittadino.
Può sembrare, perfino bizzarra, l’iniziativa volta a sollecitare e promuovere una qual forma di partecipazione e di rappresentanza affinché “i cittadini, attori sociali, possano dare libera espressione alla propria soggettività e risposte ai propri bisogni”. Ci sono momenti in cui più inteso è il bisogno di sapere. Fortunato colui il quale sente questo bisogno nell’adolescenza: opportunamente motivato, muta l’obbligo in facoltà e ne fortifica il temperamento. L’età adulta implica l’impegno di mettere in pratica le proprie attitudini congruenti con l’attività da svolgere, la cui efficacia è proporzionale alla cognizione ed alla possibilità di seguirne l’evoluzione: ne consegue l’implicito bisogno dell’utile aggiornamento. In fine arriva quel periodo della vita dove l’individuo deve potere esprimere tutto il suo carattere, libero dagli impegni sociali che ne possono avere condizionato la vita stessa. Sono poche le persone che possono avere vissuto la vita lavorativa senza ledere il prossimo, nel pieno soddisfacimento delle proprie inclinazioni. E’ compito della Società, dare la possibilità a chi ha vissuto una vita lavorativa lontano dal proprio essere Vivo, quando è ancora nella piena capacità di recepire il piacere di esprimere le proprie passioni.
Nel momento che si esprime il bisogno di notizie e di informazione, il bisogno di comunicare: si determina la situazione in cui “la lotta, il movimento, il partito diventano un fatto esistenziale”. Ci sono termini del dibattito politico, i cosiddetti luoghi comuni, di cui è imbastito il linguaggio che è quello tecnico della politica. Ebbene se si riesce con un’iniziativa, movimentata da un continuo dialogo, a digerire questi luoghi comuni, si riesce a farli digerire anche ad altri. Si riesce a farli diventare viventi. E questo non è poco.
Per secoli l’uomo ha accettato il luogo comune[1] che fosse il Sole a girare intorno alla Terra e non si è mai posto domande su questa verità; poi gli è stato detto che è vero il contrario e ha accettato il nuovo luogo comune. Oggi affermare l’una o l’altra cosa è indifferente, ma ciò vale solo per coloro che conoscono bene la fisica e che sanno che il moto relativo dei corpi non è affatto un luogo comune. Un concetto, quindi, è o non è un luogo comune non tanto per quello che afferma, quanto piuttosto in funzione del destinatario del messaggio.
Fin qui dei principi e delle convinzioni, inseriti in un contesto utilitaristico nel tentativo di dare un senso all’argomento, con la finalità di originare un’indagine sulle condizioni che costituiscono l’ostacolo alla soddisfazione dei bisogni. Oggi i bisogni sono completamente diversi e, per la dinamicità dei contesti, molto spesso essi non sono noti a priori, non discendono cioè automaticamente dalle caratteristiche individuali (età, genere, collocazione geografica, presenza di handicap, istruzione e così via), ma dipendono anche, se non soprattutto, dai percorsi delle persone nella società e nel mercato del lavoro. Finora si è proceduto prevalentemente in base alla definizione di target di bisogno, mentre occorrerebbe tenere in considerazione i percorsi delle persone, introducendo anche approcci che mirano a gestire l’insieme di problemi cui una persona è soggetta. Questo non significa abbandonare completamente l’approccio dei gruppi bersaglio, ma integrarlo con tematiche di tipo trasversale, che spesso ci segnalano le moderne emergenze. Il reddito, la casa, i problemi di cura, la carenza di una cultura di comunità sono alcune di queste. Per quanto possibile si è voluto sottolineare: sia la Società che ha l’obbligo di dare dignità all’Individuo, sia il desiderio dello stesso individuo di vedersi realizzato secondo le proprie predisposizioni. La volontà di muoversi nell’oggettività, ci ha indotto a procedere nell’ambito delle percezioni della nostra comunità. La motivazione che ha spinto l’azione finalizzata ad evidenziare le cause che implicano lo spostamento delle modalità di individuazione delle tematiche trattate, nasce a sua volta dal bisogno di una cultura di comunità che in ambito italiano è ancora carente pur disponendo di opportunità che altri paesi non hanno.
Di seguito, a conclusione, si riporta un articolo di psicologia[2] che pare molto appropriato. Più che un compendio una trattazione sulla motivazione, individuando due tipologie differenti: le motivazioni primarie e le motivazioni secondarie. Il componimento chiude con un modello di crescita motivazionale in cui si possono individuare sei fasi successive, di bisogni, andando dalla più elementare e basilare alla più complessa ed elevata.
“La personalità dell’individuo può essere concettualizzata come la combinazione di una parte razionale, legata ai processi cognitivi, ed una parte più istintuale, legata alle emozioni e alle motivazioni personali. La motivazione è un aspetto centrale per la comprensione del comportamento umano. Gli autori che ne hanno approfondito la conoscenza ne hanno individuato due tipologie differenti: le motivazioni primarie e le motivazioni secondarie. Che cosa intendiamo con il termine Motivazione? La spinta o stato interiore che orienta l’organismo verso un’azione finalizzata al raggiungimento di un determinato scopo od obiettivo. Il concetto di motivazione si rivolge alla spiegazione di tre aspetti generali della condotta:
a) tende a chiarire quale sia il meccanismo che stimola e fa scattare la messa in atto di una particolare condotta;
b) chiarisce l’origine della stimolazione attivante e la meta, o verso, della condotta attivata;
c) serve ad interpretare le differenze individuali di reattività (Cofern, 1979).
La motivazione di un soggetto è stata studiata ed analizzata a vari livelli, a seconda del tipo di motivazione che viene presa come punto di riferimento. La condotta, infatti, può essere motivata da spinte di tipo elementare o basilare per la sopravvivenza dell’individuo, oppure può essere guidata da determinati concetti o schemi mentali: nel primo caso parliamo di motivazioni primarie, mentre nel secondo caso di motivazioni secondarie. La motivazione primariaè comunemente spiegata come l’esito di uno scompenso in un processo di tipo omeostatico, i cui meccanismi di base sono fondamentalmente di tipo fisiologico. I modelli teorici che si sono maggiormente adoperati allo studio di questo primo tipo di motivazione sono i Modelli Pulsionali Biologici di carattere meccanicistico. Essi partono dall’assunto imprescindibile del concetto di bisogno, che deriva direttamente da quelle che sono le necessità biologiche dell’organismo (come la fame e la sete).
Al concetto di bisogno si lega direttamente quello di attivazione: la condotta finalizzata, e quindi la motivazione antecedente all’azione, dipendono dall’innesco di un meccanismo di tipo fisiologico, che “scatta” solo quando i segnali di bisogno superano uno specifico livello di soglia (Stegagno, 1991), e permettono, di conseguenza, di far discendere i segnali di bisogno al di sotto di tale soglia di attivazione così da inibire la motivazione. Questo processo generale di mantenimento di un determinato equilibrio dell’organismo attraverso un meccanismo di controllo a retroazione di tipo automatico, viene detto omeostasi, la cui finalità è quella di preservare la stabilità dell’ambiente interno dell’organismo di fronte a variazioni dell’ambiente esterno. Il grande gruppo delle motivazioni secondarie, invece, si colloca ad un livello diverso dalle motivazioni appena descritte, dal momento che:
Ø non sono essenziali per la sopravvivenza;
Ø si rilevano solo negli animali filogeneticamente più evoluti;
Ø nell’uomo compaiono più tardivamente nel corso dello sviluppo.
Una delle principali motivazioni secondarie è la motivazione al successo, intesa come la spinta a compiere una determinata azione dettata dal desiderio di raggiungere un certo risultato, descrivibile in termine di successo. In quest’ottica non è motivante il risultato in sé, quanto il fatto di considerarlo soggettivamente “meritato”, cioè il fatto di attribuire il risultato stesso come dovuto al personale impegno e merito.
Per meglio comprendere il vero significato di queste motivazioni superiori, è doveroso menzionare le teorie dell’attribuzione, che spiegano perché, di fronte al medesimo risultato, molto spesso le persone cambiano notevolmente il loro livello di motivazione.
La spiegazione sembra risiedere nel fatto che esistono diverse tipologie di cause alle quali le persone attribuiscono la ragione del proprio successo o fallimento, ed in base a quale di queste viene considerata attuale può variare, in positivo o in negativo, la motivazione al comportamento. In altre parole, sembra che il livello di motivazione del singolo dipenda dalle cause alle quali la persona ritiene di attribuire il risultato raggiunto. Le possibili cause possono essere così descritte:
Ø Abilità. Il ripetersi di una serie di successi nello stesso compito induce nel soggetto l’idea che questo non possa essere casuale, e quindi lo spinge ad attribuire tale successo alla sua capacità personale.
Ø Impegno/sforzo. Il livello di soddisfazione aumenta in proporzione quasi lineare con la fatica ed il costo; se la persona si è impegnata tanto da sentirsi stanca, quindi, può attribuire il successo all’impegno profuso.
Ø Difficoltà. Se la maggior parte delle persone riescono a fare la stessa cosa, il soggetto può attribuire il successo alla scarsa difficoltà del compito.
Ø Fortuna. Se la persona si accorge che l’abilità e l’impegno non influenzano il risultato, può attribuire questo al caso e decidere che il successo in quel compito è una semplice questione di fortuna.
Il livello di motivazione, dunque, può mutare radicalmente a seconda del giudizio attributivo che le persone elaborano. Gli autori che si sono maggiormente occupati della tassonomia delle motivazioni e della loro organizzazione in un modello gerarchico sono stati Murray e Maslow tra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta. In particolare, Maslow nel 1982 propone un modello di crescita motivazionale in cui vengono messe in evidenza sia la gerarchia sia l’ontogenesi delle diverse motivazioni. Secondo l’autore, nel corso della vita si possono individuare sei fasi successive, andando dalla più elementare e basilare alla più complessa ed elevata:
1) Bisogni fisiologici: la necessità di soddisfare i bisogni legati al corpo ed alla sopravvivenza sono i primi a scattare alla nascita, e tendono ad essere soddisfatti di volta in volta senza possibilità di procrastinazione.
2) Bisogni di sicurezza: si manifestano dopo l’appagamento dei bisogni fisiologici, corrispondono alla capacità di operare una distinzione tra sé e non sé (rudimento di identità) e si mostrano come ricerca di contatto e di protezione da parte dell’individuo.
3) Bisogno di amore e di appartenenza: desiderio di ricevere e di dare amore, che nasce solo dopo avere soddisfatto i bisogni precedenti.
4) Bisogno di riconoscimento: esigenza di avere, dalla relazione con il partner, il riconoscimento di ciò che si fa e del risultato raggiunto.
5) Bisogno di realizzazione di sé: corrisponde alla fase più elevata dello sviluppo e della comprensione di se stesso.
6) Bisogno di trascendenza: bisogno di superare i propri limiti, cercando di collocarsi in una prospettiva sopra-individuale, di entrare a fare parte di un mondo superiore ed essere partecipe del divino.
Secondo questo modello, un bisogno insoddisfatto ad un livello basso concentra l’energia a quella fase e non lascia spazio alcuno per i livelli superiori; i livelli più alti, dunque, si reggono sulla solida soddisfazione di quelli più bassi. Maslow, conclude la sua teorizzazione, definendo il suo modello come “globale e dinamico”, in quanto le sue fasi superiori comprendono sempre anche quelle inferiori in un disegno evolutivo di tipo globale, in cui le forze associate alle diverse fasi ipotizzate sono in un equilibrio che muta continuamente in maniera dinamica”.
Bibliografia[3]
[1] http://www.cosediscienza.it/index.html
[3] Bandura A., 1976. L’apprentissage social, Mardaga, Bruxelles.
Cofern N.C., 1979. Motivazione ed emozione. Franco Angeli, Milano.
Maslow A.H., 1982. Motivazione e personalità. Armando Armando, Roma.
Murray H.A., 1938. Explorations in personality. Oxford University Press, New York.
Murray H.A., 1964. Motivation and emotion. Prentice-Hall, New Jersey (trad. it.: Psicologia dinamica, Martello, Firenze).